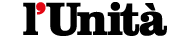Caro Direttore,
nell’ultimo numero dell’Unità vi sono ben due articoli che sostengono argomenti contrari a una riforma della Costituzione in senso presidenzialista. Chiedo pertanto una cortese ospitalità per alcune mie considerazioni sul quotidiano da Lei diretto. In primo luogo, io credo che la Legge fondamentale del 1948 vada bene così. Anzi sarebbe stato meglio evitare le modifiche più o meno ampie apportate nel tempo attraverso le procedure di cui all’articolo 138. Questa convinzione non deriva dalla retorica di Roberto Benigni: non esiste la Costituzione più bella del mondo e quindi neanche la nostra lo è. Il problema è un altro: le norme, anche quelle costituzionali, evolvono nel tempo, si adattano alle modifiche della politica, della società, si adeguano attraverso la prassi ma soprattutto attraverso la giurisprudenza costituzionale.
Potremmo scrivere un trattato per dimostrare la fondatezza di questo assunto. Ho sempre considerato una cosa priva di senso impegnarsi nelle modifiche a una Costituzione (voluta) rigida, quando i problemi vari di efficienza stavano e stanno ancora, per quanto riguarda il potere legislativo, nei regolamenti parlamentari, la cui complessità barocca è un residuo del consociativismo della Prima Repubblica (Dio l’abbia in gloria!). Sulla base di queste opinioni ho sempre votato (ora con un NO ora con un SÌ a seconda del tipo di referendum su cui eravamo chiamati a pronunciarsi) in senso contrario alle (contro)riforme, soprattutto a quelle – come nella legge Renzi-Boschi – che finivano per mettere nella Costituzione delle norme di mero carattere regolamentare, nell’indifferenza di tanti costituzionalisti. Oggi la suggestione di una “democrazia governante” si è spostata dal potere legislativo a quello esecutivo. Giorgia Meloni ha aperto un confronto con i partiti di opposizione con la consapevolezza di avere un vantaggio: tutte le forze politiche, magari in modi differenti e in epoche diverse, si sono “compromesse” con la retorica delle riforme, tanto da rendere politicamente insostenibile il rifiuto a discuterne.
Personalmente, al di là del merito, ritengo che sarebbe una forzatura avvalersi delle procedure di cui all’articolo 138 Cost. per introdurre modifiche radicali come, nell’ordine, il presidenzialismo (o il semipresidenzialismo) oppure il cosiddetto premierato (con le relative elezioni dirette di chi è chiamato a ricoprire queste funzioni). Considero il “premierato” la peggiore delle soluzioni possibili. Paragonare un premier al “sindaco d’Italia” vuol dire subordinare il Parlamento, nella sua composizione e durata, a questa figura. Non credo che ci siano minacce per la democrazia né rischi di autoritarismo nelle proposte di revisione presenti nel dibattito. Solo pasticci istituzionali. Cambiare la natura parlamentare di una Repubblica e riscriverne la legge fondamentale con modifiche strutturali sarebbe compito di un’assemblea costituente, eletta con criteri proporzionali.
Diverso sarebbe il caso dell’elezione diretta del capo dello Stato, a mio parere assolutamente compatibile con la natura parlamentare della Repubblica. (guai a confondere questa procedura con il presidenzialismo). Infatti, in Europa (una circostanza che nessuno ricorda mai) i presidenti sono eletti dal popolo in quasi tutti i Paesi dove non regna una monarchia dinastica. Peraltro, l’elezione diretta del capo dello Stato potrebbe essere presentata come un problema reale, se si considerano le esperienze – un po’ patetiche e disarmanti – che hanno contraddistinto la rielezione dei due ultimi presidenti della Repubblica. Si direbbe quasi che l’Italia sia scivolata inconsapevolmente in una monarchia elettiva. Ricoprire la suprema magistratura dello Stato per 14 anni è, infatti, un tempo congruo per un sovrano; le sue eventuali dimissioni finirebbero per somigliare ad un’abdicazione (come in pratica fu quella di Giorgio Napolitano). Che, poi, un presidente eletto dal popolo sia più divisivo di uno eletto dal Parlamento è solo un teorema non dimostrato. Con la stessa logica sarebbe divisivo un capo dello Stato eletto dalla sola maggioranza al quarto scrutinio.
Ma c’è di più. L’elezione diretta del presidente della Repubblica era una proposta condivisa nella relazione conclusiva della Bicamerale presieduta da Massimo D’Alema (che Lei direttore ben conosce) nel 1997 e nel disegno di legge costituzionale che ne era scaturito. Il relatore su quel punto fu Cesare Salvi (ex Pci d’antan) e sicuramente una Sua antica conoscenza. Peraltro quella relazione e quel disegno di legge uscirono in un momento di massimo fulgore di Silvio Berlusconi, il quale – Lei lo riconoscerà perché è un galantuomo – era considerato molto più pericoloso di quanto lo sia e lo sarà mai Giorgia Meloni. Per quanto riguardava l’elezione diretta del Capo dello Stato l’articolo 64 stabiliva: “Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età”. La durata del mandato era pari a sei anni ed era prevista l’eventuale elezione solo per un altro mandato. Era altresì indicata la procedura per le elezioni al successivo articolo 67. Le candidature venivano presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da cinquecentomila elettori, o da parlamentari, rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, consiglieri regionali, presidenti di Province e sindaci, che vi provvedevano nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge. Era eletto il candidato chi avesse ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato avesse ottenuto tale maggioranza, si procedeva il quattordicesimo giorno successivo al ballottaggio tra i due candidati che avevano conseguito il maggior numero dei voti. Era addirittura contemplato il caso della morte e dell’impedimento permanente del Presidente e le relative procedure per la vacanza della carica e per la sostituzione. Una modifica siffatta sarebbe meno invasiva dell’ordinamento vigente, non comporterebbe una revisione dei poteri ora previsti, rispettivamente, per il capo dello Stato, il governo e il Parlamento, il quale conserverebbe la sua centralità.
Certo, ci sarebbero degli effetti politici significativi. Ma non si venga a dire che si mancherebbe di rispetto all’attuale presidente: se una norma è utile – e in questo caso potrebbe esserlo – basterebbe prevedere una procedura di transizione. Il Parlamento nella scorsa legislatura non venne considerato decaduto dopo che la riforma, confermata da un referendum, l’aveva mutilato. Per inciso è il caso di ricordare anche l’articolo 57: “Con leggi costituzionali possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per le altre Regioni” (diverse delle classiche a statuto speciale). A prova del fatto che tutti, prima o poi, hanno trescato col federalismo e affini. Grazie e buon lavoro.