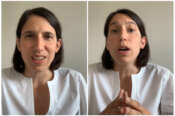Il nuovo Pd e le sfide estere
Intervista a Piero Fassino: “L’orizzonte del Pd deve essere il mondo”
Noi dovremo batterci per una Europa massima, un’Europa minima è un danno
Editoriali - di Umberto De Giovannangeli

Per Piero Fassino, già segretario nazionale dei Democratici di sinistra e sindaco di Torino, la politica estera è sempre stata una passione coltivata e praticata nel corso della sua storia politica, da sottosegretario agli Esteri, ministro per il Commercio con l’estero, Inviato europeo, presidente della Commissione Affari esteri della Camera dei deputati e oggi vicepresidente della Commissione Difesa. La guerra in Ucraina, la crisi in Kosovo, il futuro dell’Europa e un pensiero forte della sinistra sul mondo. Le grandi sfide a cui il nuovo Pd e la sinistra europea non possono sottrarsi.
Una sinistra senza una visione del mondo, senza un pensiero forte sui grandi temi che scuotono il pianeta, non è una sinistra che si condanna alla marginalità e all’inefficacia?
Oggi nessuna forza politica può pensare i propri obiettivi, la propria azione e la sua strategia, se non in quadro internazionale. Una forza politica che voglia candidarsi a guidare il Paese deve dotarsi di una visione internazionale adeguate, con proposte e obiettivi che stiano dentro questa visione. D’altra parte, la sinistra nasce con una cultura internazionalista. Fin dagli albori nella metà dell’800 e via via lungo tutto il ‘900, la sinistra è stata sempre portatrice di una visione internazionalista, cosmopolita, collegando sempre la dimensione nazionale a una visione più ampia e più larga. Oggi questo approccio è tanto più necessario: ogni giorno la nostra vita è profondamente influenzata e condizionata da fattori globali. Viviamo da un anno e mezzo con una guerra alle porte di casa che incide profondamente sulle scelte di politica estera, in quelle di politica energetica e di sviluppo economico, nei sentimenti dell’opinione pubblica. Siamo dentro un mondo che vive drammaticamente il cambiamento climatico con tutte le sue conseguenze sugli assetti geopolitici e sulla vita delle persone. Viviamo tutti i giorni dentro un mondo segnato dai flussi migratori che non si gestiscono soltanto sulla base di politiche nazionali. La globalizzazione ha riaperto il grande tema di come si governano i mercati e gli scambi a livello internazionale e sempre più frequentemente assistiamo a guerre commerciali, come quelle tra gli Stati Uniti e la Cina, tra l’Europa e la Cina. Da ogni punto di vista oggi il pensiero politico di un partito non può che collegarsi dentro una dimensione internazionale.
Il “nuovo Pd” si sta attrezzando per questo cimento?
Non dimentichiamo mai che tra le ragioni fondative del Pd, quando gli demmo vita nel 2007, vi era anche una motivazione che guardava un orizzonte largo. Fondammo il Pd perché pensavamo indilazionabile un profondo rinnovamento culturale, programmatico e politico delle forze di sinistra e riformiste in Europa. Ricordo che allora, quando come segretario dei Ds andavo a incontrare i miei omologhi dei partiti socialisti e socialdemocratici per spiegare perché davamo vita al Partito democratico, i loro sguardi erano piuttosto scettici. Oggi possiamo ben comprendere che avevamo ragione se solo guardiamo a come in questi anni tutte le forze di sinistra, socialiste, socialdemocratiche, riformiste hanno subito sconfitte e smottamenti elettorali a dimostrazione che quella esigenza di un profondo rinnovamento era assolutamente necessaria allora e oggi lo è ancora di più. Il Pd è nato per essere una forza che contribuisce al rinnovamento delle forze di sinistra, riformiste e democratiche europee e a maggior ragione ha tra i suoi obiettivi questo. Anche alla luce di quanto è avvenuto in queste settimane.
Vale a dire?
Siamo a pochi giorni da una sconfitta elettorale in Grecia, e poi in Spagna. Da un voto in Turchia che ha visto ancora una volta Erdogan prevalere. Un mese fa in Finlandia le forze conservatrici hanno vinto. Perfino in Svezia i populisti sono in crescita. In Francia i sondaggi in questo momento danno Marine Le Pen come il leader più votato. Tutto questo pone il problema di un profondo rinnovamento della sinistra. La dico così: il ‘900 è stato il secolo della sinistra. Il secolo nel quale la sinistra con le sue lotte ha affermato e fatto diventare universali i suoi valori, anche passando attraverso tragedie immani, quali il fascismo, il nazismo, lo stalinismo. Il ‘900 è stato il secolo in cui la sinistra ha ottenuto il suffragio universale, ha costituzionalizzato il mercato, ha inventato il welfare. Il ‘900 è stato il nostro secolo, il secolo dei nostri valori, che sono diventati universali. Pensiamo a come l’8 marzo, una ricorrenza del movimento operaio internazionale, la Festa della donna, è oggi celebrata da tutti, anche da quelli che ne avevano negato il valore. Questo nuovo secolo, nei suoi primi vent’anni, è invece segnato da una egemonia della destra.
Perché?
Facciamo i conti con un paradosso. La sinistra nasce internazionalista, fin dalle sue origini, ma la sua forza nel ‘900 l’ha sviluppata nella dimensione nazionale, in ogni Paese, affermando in quella dimensione la sua centralità e egemonia, parola cara a Gramsci, culturale e politica. In Italia, in Francia, in Germania, nei Paesi nordici. In Europa e non solo. Ma una sinistra nata con una visione internazionalista e cosmopolita, dalla globalizzazione è stata spezzata. E nella globalizzazione sono fino ad oggi risultate vincenti le forze di destra, che peraltro all’inizio in nome di una cultura protezionistica, la globalizzazione la contestavano. Altro paradosso. Insomma, siamo dentro uno scenario di grandi cambiamenti che richiede alla sinistra un pensiero nuovo. Quando fondammo il Pd, io usai una formula: un partito nuovo, capace di avere un pensiero nuovo per un secolo nuovo. Questa sintesi vale a maggior ragione oggi per contrastare l’egemonia della destra e riaffermare la centralità dei nostri valori.
Tra le sfide del presente c’è anzitutto quello della guerra. Una guerra che investe, non solo territorialmente, l’Europa. L’Ucraina, ma adesso sembra riesplodere anche la crisi balcanica.
Dal 1945 ad oggi di guerre ne abbiamo conosciute in Europa. I Balcani negli anni’90, negli stessi anni e più recentemente nel Caucaso, oggi in Ucraina. Tutte guerre scoppiate in territori esterni all’Unione Europea. L’Unione Europea si è confermata invece uno spazio di stabilità, di pace e di sicurezza. Dentro lo spazio dell’Unione Europea guerre non ce ne sono state e ci siamo abituati all’idea che la guerra era qualcosa che non ci riguardava più, che non c’investiva. Anche quelle in Caucaso e nei Balcani, le avevamo lette come guerre locali, che non ci riguardavano. Una lettura miope. Ci ritenevamo comunque al sicuro da una guerra. La guerra in Ucraina ha cambiato lo scenario.
Da cosa dipende questo cambiamento?
Dal fatto che quella guerra è stata scatenata da uno dei grandi protagonisti della vita politica del mondo, la Russia. Dal momento in cui Putin ha invaso l’Ucraina, quella guerra non è più definibile come una guerra “locale”, ma è un conflitto che investe il mondo, in particolare l’Europa. Tant’è che intorno alla guerra d’Ucraina si è prodotta la lacerazione di quel rapporto tra Occidente e Russia, che è stato uno degli elementi fondamentali del sistema multilaterale di gestione del mondo dalla caduta del muro di Berlino ad oggi. La reazione non poteva che essere di rifiuto, condannando l’atto unilaterale d’invasione della Russia e sostenendo l’Ucraina in lotta per difendere la propria sovranità e libertà. Non solo. Putin ha fatto un passo in più che rende ancora più complessa la situazione.
Quale sarebbe questo passo in più?
Non solo ha invaso, ma ha “annesso” una parte dell’Ucraina, dicendo “questo territorio è mio, lo includo nel mio spazio e non lo restituisco più” rendendo così difficile un accordo di pace. Tutti diciamo bisogna fermare le armi. Ed è giusto, perché ogni giorno di guerra significa nuove sofferenze, altri morti e distruzioni. Si moltiplicano i tentativi negoziali, dalla Cina al Papa. E anche l’Europa deve essere impegnata nella costruzione di una soluzione di pace. Ma tutti questi tentativi devono fare i conti con un nodo: l’integrità’ territoriale dell’Ucraina coincide con i confini del 22 febbraio 2022 o no? Fino ad oggi l’Ucraina, e noi tutti occidentali, abbiamo detto di sì, quei confini non sono modificabili. Altri, come la Cina, sostengono invece che la Russia si deve tenere i territori che ha annesso e che solo così può aprirsi uno spazio negoziale. Ma gli ucraini, legittimamente, non accettano di veder mutilato il loro Paese. Il vero nodo con cui bisogna fare i conti è questo. Quel che vuole Kiev è l’opposto di ciò che pretende Mosca. Quale può essere un punto di compromesso accettabile dalle parti? È con questo interrogativo che si devono misurare tutti gli sforzi per la pace. Ma la guerra in Ucraina, come prima quelle nei Balcani e nel Caucaso evidenziano una cosa che l’Europa tarda a capire.
Cosa non capisce?
Che se vuoi dare sicurezza all’Europa intera, allora devi preoccuparti di come affronti quei conflitti e come porti quei Paesi dentro l’Unione Europea. Se l’Unione Europa si è confermata essere l’unico spazio di stabilità e di pace, si garantiscono sicurezza e stabilità alle aree che oggi sono insicure se le si aggancia all’Europa. E qui c’è un gravissimo ritardo dell’Unione Europea, non solo di Bruxelles, quanto assai di più di alcune capitali europee che in questi anni hanno frenato l’allargamento dell’Unione. Un atteggiamento miope che lascia quei paesi nella instabilità e non garantisce sicurezza all’Europa.
Cioè?
Si è promessa l’integrazione europea ai Balcani all’indomani della pace di Dayton, 1995, poi si è consolidata quella prospettiva nel 2003 con il Consiglio europeo di Salonicco che ha avviato la strategia d’integrazione. Siamo nel 2023. Sono passati 28 anni da Dayton e 20 anni da Salonicco. Fino adesso dei Paesi dei Balcani occidentali ne è nella Ue solo uno: la Croazia (che peraltro non vuole essere definita balcanica). Con Serbia e Montenegro c’è un negoziato aperto che si protrae da anni; solo da pochi mesi si è deciso di aprire i negoziati con Albania e Macedonia del Nord, mentre non c’è ancora una prospettiva per Bosnia e Kosovo. Quando un obiettivo viene continuamente evocato e promesso senza che poi si realizzi, perde di credibilità. La lentezza europea ha prodotto tre risultati negativi: primo, frustrazione nelle opinioni pubbliche e nei governi dei Paesi dei Balcani occidentali. Abbiamo detto loro continuamente “le nostre porte sono aperte, voi sarete integrati”, ma intanto si dilazionano sempre i tempi. In questo modo abbiamo lasciato libero campo a nuovi attori, Russia, Cina, Turchia, Emirati Arabi Uniti, tutti presenti nei Balcani, come lo sono nel Caucaso. E infine la lentezza di Bruxelles ha fornito ai paesi candidati l’alibi per rallentare le riforme necessarie ad allineare le proprie leggi agli standard europei in materia di giustizia, tutela delle minoranze, stato di diritto, lotta alla corruzione. E così in uno scenario incerto e nebuloso riemergono le nostalgie del passato: il nazionalismo, la purezza etnica, le piccole patrie, che sono state per secoli il vero cancro dei Balcani. La geopolitica ha perfino coniato la parola “balcanizzazione” per definire una situazione caratterizzata da latente e continua conflittualità e frammentazione. Se l’Unione Europea tarda ancora rischiamo di favorire ancora quelle dinamiche. Non mi stupisco della crisi in Kosovo, dove serve un salto di qualità nell’opera di pacificazione messa in campo dalla UE. Segnalo peraltro che il Montenegro vive da due anni una costante crisi politica con un cambio continuo di primi ministri. E che la lentezza europea ha penalizzato in Macedonia del Nord proprio le forze più europeiste che, su richiesta di Bruxelles, avevano accettato di darsi un nome che ponesse fine ai veti della Grecia. Lo hanno fatto, ma le porte sono rimaste chiuse fino a pochi mesi fa. Di fronte alla crisi del Kossovo, l’altro ieri Ursula von der Leyen ha dichiarato di voler rilancia la strategia di integrazione dei Balcani. Bene, purché sia rapida.
Guardando ad un appuntamento di grande importanza come saranno le elezioni europee del 2024. Una sinistra lungimirante come dovrebbe impostare la sua iniziativa?
Rilanciando con forza il tema dell’Europa, come la condizione per lo sviluppo di ogni Paese europeo. Proprio perché viviamo in un mondo globale, nessun Paese europeo da solo ce la fa. Quando devi fare i conti con la Cina, 1 miliardo e 300 milioni di persone e una crescita del Pil di 9-10 punti all’anno. Quando devi fare i conti con l’India, 1 miliardo di persone, e con tutta una serie di Paesi emergenti che ormai sono attori del mercato mondiale, non puoi pensare che l’Italia o la Francia o perfino la Germania possano competere da sole. Mentre un’Unione europea, una realtà di 550 milioni, che metta a fattore comune il suo patrimonio economico, produttivo, tecnologico, sociale, politico, diventa un attore strategico in grado pesare nel mondo globale e anche di tutelare i suoi interessi. Perché gli interessi ci sono. Non è che in nome della globalizzazione o dell’Europa spariscono gli interessi delle nazioni. Ma il modo migliore per tutelare quegli interessi è una Europa forte, non una Europa debole.
In questo, la destra italiana?
Giorgia Meloni ha un approccio europeo strumentale, opportunistico: “prendo solo quello che i piace e lascio quello che non mi soddisfa.” Ma non stai in Europa così. Stai in Europa se assumi quella dimensione e ottimizzi tutto quello che ti piace e riduci i rischi di quello che non ti piace, e stai lì e fai valere il tuo punti vista cercando una sintesi in cui tutti i Paesi si possano riconoscere. Serve una Europa molto più forte, anche riformando il suo modo di decidere e operare, liberandosi di approcci burocratici in cui i cittadini non si riconoscono. Questa deve essere la nostra parola d’ordine a fronte di una destra che tenderà a ridurre il ruolo dell’Europa al minimo necessario. Ma un’Europa minima è un danno in primo luogo per i Paesi più esposti come l’Italia. Noi dovremo batterci per una Europa massima, non in termini ideologici ma dimostrando concretamente, con proposte forti come si possano dare risposte in una chiave europea a nodi cruciali. Si pensi al problema fiscale che vede uno scenario di dumping fiscale con Paesi che hanno aliquote basse. L’armonizzazione fiscale è una battaglia a tutela dell’Italia. Così come ottenere una strategia europea sulle migrazioni corrisponde agli interessi dell’Italia. Lo scenario delle prossime elezioni europee è a rischio. Se stiamo ai risultati elettorali degli ultimi due-tre anni e non si inverte la tendenza, la famiglia socialista potrebbe conoscere una riduzione della propria forza aprendo le porte ad un accordo tra popolari e conservatori. Dopo l’Europa dei padri fondatori e l’Europa dell’Euro, dobbiamo lanciare con determinazione la proposta di una “terza fase” della vita dell’Unione europea per realizzare un più alto livello di integrazione in ogni campo. Una sinistra che si batte per vincere o assume questo orizzonte o resterà al palo.