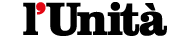Anche chi non sia del mestiere può leggere senza problemi le centoundici pagine della sentenza del tribunale di Brescia che motivano la condanna inflitta, per rivelazione di segreto d’ufficio, al dottor Piercamillo Davigo. È una lettura di interesse non tanto per il ragionamento che ha portato il collegio giudicante a ritenere il dottor Davigo responsabile di aver commesso quel delitto, ma per la rassegna di strepitose circostanze che contornavano il ciclone degli accadimenti. Viene in mente quella pagina delle Memorie di Adriano: “…baci furtivi sulle scale, sciarpe fluttuanti sui seni, commiati all’alba, e serti di fiori lasciati sulle soglie”.
Solo che qui si stava sulle scale, anzi “nella tromba delle scale”, e a rendere memorabili i giudiziosi accoppiamenti non c’erano gli ardori dell’amante “che stordivano come una melodia frigia”, ma gli occhioni celesti e il profilo post-vaffanculo del presidente della Commissione antimafia, senatore Nicola Morra, il quale riceveva le illecite confidenze del dottor Davigo per poi sentirsi dire in sentenza (era testimone) che “non ha brillato per capacità comunicativa”, povera stella, coi giudici impietosamente incattiviti sulla “sospetta insipienza” dimostrata dal teste nel non rispondere in modo chiaro alla domanda ovvia, e cioè se il conciliabolo con il dottor Davigo fosse avvenuto in via amicale o istituzionale. Ed evidentemente lo sventurato, rispondendo in quel modo, cioè non rispondendo, dimenticava ciò che aveva dichiarato in precedenza (“In quel momento non parlavo con lui – vale a dire con Davigo, n.d.r. – nella mia veste di Presidente della Commissione Nazionale Antimafia e il colloquio aveva carattere privato”).
Altro che sciarpe fluttuanti, qui frusciavano le veline dei verbali prima inguattate e poi disseminate in favore dei confidenti, quelle che si potevano rammostrare al Csm perché non c’era il segreto – questa la tesi della difesa – e quelle che invece si potevano ostentare al suddetto Morra perché, lui sì, era… “tenuto al segreto”. E qui in effetti il lettore comune perde il filo, perché non capisce più come funzioni questa storia del segreto: che non c’è quando si tratta di divulgarlo ad alcuni, ma che ricompare per trasferimento in tromba di scale per vincolare non già chi lo divulga, bensì chi lo riceve, vale a dire Morra: che però dice di sé stesso di non essere lì come presidente dell’Antimafia, cioè il soggetto pretesamente tenuto al segreto, ma in veste di non si sa cosa. E dice pure, Morra, che Davigo non gli aveva riferito che i verbali erano secretati. Doveva essere sottinteso, boh, vai a capire.
E sugli usci, poi, non serti di fiori, ma ancora quelle veline, finite in impreveduto svolazzo alle porte delle redazioni e delle residenze private del giornalismo d’inchiesta – scelto a caso, come vedremo tra poco – il quale però, per per una volta, non le pubblicava immediatamente (prima era meglio chiedere consiglio). C’è per esempio questo Antonio Massari, del Fatto Quotidiano, anche lui testimone. Il presidente del tribunale gli domanda se “i giornalisti avevano legami con personaggi che gravitavano intorno al Consiglio Superiore”, e quello risponde che “ha dei contatti, come è giusto che sia, però le fonti sono sempre state riservate”. Peccato non sapere se ci sono giornalisti che lavorano sulla scorta di contatti con personaggi gravitanti intorno al Csm. Mica è necessariamente illecito, figurarsi, ma il lettore (abbiamo il “dovere” di informarlo, giusto?) potrebbe essere interessato a sapere se il Consiglio Superiore della Magistratura è il centro di un sistema satellitare che organizza lo smistamento dei “plichi anonimi” di cui parla la sentenza. Macché.
Poi c’è quest’altra, Liana Milella, di Repubblica, testimone a sua volta e anch’ella destinataria di quei plichi, il cui invio era stato preannunziato da una telefonata anch’essa anonima: una voce di donna con accento settentrionale (impagabili le pagine della sentenza che indugiano sulle abilità della giornalista di “distinguere una voce del nord da una voce del centro e una voce del sud”). Milella riceve l’incartamento, cioè il pacco di veline, accompagnato da una lettera che sparla del procuratore della Repubblica di Milano e del procuratore generale della Cassazione: e che fa? Dice che si sente “prigioniera di un segreto”: e allora porta il plico alla Procura di Roma, conservando tuttavia “una copia degli atti”.
Poi evidentemente qualcosa o qualcuno sprigiona la giornalista dal segreto che ne raggelava gli intendimenti, e lei decide allora di passare le veline (così almeno dice la sentenza, pag. 53, riga 8 e seguenti) a uno notoriamente abituatissimo al riserbo assoluto e totalmente estraneo anche al sospetto di qualche eccentricità nell’interpretazione delle funzioni consiliari: tale Luca Palamara. E qui il solito lettore un po’ tardo capisce che il segreto che ti sconsiglia di pubblicare la notizia è lo stesso che ti induce a passarla a quello che i giornali, tra i quali il tuo, definiscono come il protagonista del più grande scandalo giudiziario della storia repubblicana.
Poi la sentenza si intrattiene sui fatti mirabili di cui già scrivemmo qui: le chat irrecuperabili perché il cellulare ha preso umidità e il dottor Davigo se lo fa cambiare dal concessionario Apple che esegue il backup di tutto, ma non di quei messaggi (porca vacca!); i file nelle chiavette Usb, che però “si perdono sempre”, ma attenzione: i documenti non ci sono nemmeno se le chiavette non si perdono, perché vengono cancellati “per fare spazio”; le email introvabili perché gli account vengono soppressi nella cessazione dei ruoli giudiziari e istituzionali dell’imputato.
È lo “sterminio di atti, corpi di reato, chat, mail, apparecchi telefonici, pen drive ed indirizzi di posta elettronica” di cui parla la sentenza, la strana “morìa dei possibili elementi di riscontro” che il tribunale ritiene “ragionevolmente prossima” alla perquisizione subita dalla collaboratrice del dottor Davigo. Una vicenda, quest’ultima, che i giudici bresciani hanno ritenuto di non rimettere all’attenzione di “altre Autorità Giudiziarie” per gli accertamenti di ragione. E per noi bene così. Ma chissà per il giornalismo d’inchiesta.