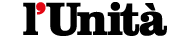“Pasolini sul fatto religioso aveva la rabbia di non poter essere cristiano, di non poter essere cattolico, aveva quasi una specie di rivolta perché la chiesa era decaduta…”. Così padre David Maria Turoldo in una intervista inedita del 1989.
Pochi conoscono l’amicizia che legò Turoldo e Pasolini – dal loro primo incontro in occasione del Vangelo secondo Matteo (1964): entrambi friulani, inclini a idealizzare il Friuli come un Eden perduto, intriso di religiosità popolare (“la terra che il mondo con invidia amava”), capaci di trasmettere in ogni parola che hanno detto una vertigine di autenticità, critici irriducibili non della modernità ma di questa modernità italiana, sfigurata e sempre incompiuta.
Dopo tanti anni di vacua retorica estremista, perlopiù riversata nell’ideologia, abbiamo perso il gusto di un estremismo autentico, come si è invece rivelato in alcune grandi figure del nostro passato recente, a cominciare dall’intrattabile don Milani.
Turoldo e Pasolini furono due “disturbatori di coscienze”(così il cardinal Martini a proposito del primo), inappartenenti ed eretici, fedeli a un loro ideale primigenio di verità: hanno costantemente sconfinato dai loro ambiti dottrinari e disciplinari, hanno smontato cliché e pregiudizi, si sono inabissati dentro le tenebre del nostro tempo cercando però uno spiraglio, mai rinunciando alla poesia e al senso del sacro.
Dove la poesia non è tanto l’attività “tecnica” di versificare (i loro componimenti sono disuguali ma contengono tutti almeno un verso memorabile) quanto l’esatto opposto della logica utilitaristica che, perfino oltre il capitalismo, inquina tutte le nostre relazioni: lo spazio meraviglioso del gratuito, del non funzionale e dell’inutile.
Mentre il sacro non riguarda qualcosa di spiritualistico, piuttosto coincide con la realtà stessa. O meglio, è solo l’altro lato appena in ombra della realtà quotidiana, l’altrove che pure si nasconde nel gesto o nell’oggetto più familiare: qualcosa che possono vedere non i sapienti e gli intellettuali ma solo i puri di cuore. Ed è il legame del tutto con un tempo ciclico, eterno.
Proviamo ad avvicinarne l’opera attraverso un libro denso di temi e ricco di contributi, ora uscito per le edizioni Aldebaran, con scritti di Marco Roncalli, Ermes Ronchi, Elio Ciol, Domenico Clapasson, Liliana Cargnelutti, Raffella Beano, Elisa Roncalli – Due anime friulane – che venerdì pomeriggio si presenta nel Comune di Casarsa (a cura del Centro Studi padre David Maria Turoldo di Coderno di Sedegliano e del Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizie, oltre che dell’Ente Regionale Teatrale).
Nelle parole di padre Turoldo il genocidio culturale e l’omologazione pasoliniani diventano le aberranti “monoculture d’America” (faceva riferimento alle serie TV che allora circolavano, Dallas e Dinasty), “tutto questo fiumane di ciarpame, di cascame che ci arriva dall’aldilà dell’Atlantico”.
La sua utopia è quella di un Friuli un po’ reale e un po’ immaginario. Friuli significa per entrambi fedeltà a una terra e ai suoi abitanti, alla cultura contadina, alla memoria dell’infanzia, ai racconti degli emigranti, e soprattutto alle loro madri friulane, che “avevano raccolto la storia della loro civiltà nella profondità della terra, nell’aria a ridosso del Tagliamento, nel vigore dei sassi…” (Raffaela Beano).
Pur nella diversità delle biografie e delle origini sociali, piccolo-borghesi e di relativo benessere per Pasolini, poverissime e desolate per Turoldo, che abitava una casa fatta di sassi di fiume. Pasolini, un non credente incantato e atterrito dal mistero dell’essere (riteneva tutto ciò che esiste “innaturale”), e padre Turoldo, che trovò Dio nella sua assenza (Ungaretti parla per lui di “assenza-presenza dell’eterno”) possono incontrarsi sul terreno friabile del sacro.
Turoldo, ipnotizzato dalla figura veterotestamentaria di Giobbe intravede attraverso di lui l’ “unica soluzione” della sua vita: “il diritto a disperare”. Per Pasolini, che intitolò una poesia “Una disperata vitalità”, le persone mature sono più felici dei giovani perché, finalmente, non sono più costrette a sperare, non si aspettano nulla dal futuro, che è in sé irreale. Nel Vangelo secondo Marco leggiamo che “il regno è una realtà visibile solo in forza di un rivolgimento interiore”.
Dunque il Regno c’è già, ma nascosto: per riuscire a “vederlo” occorre soltanto quel rivolgimento. In un articolo sul film Gli ultimi di Vito Pandolfi e dello stesso Turoldo, del 1963, ambientato nel mondo contadino friulano, Pasolini definisce il film “monotono e grigio, ma carico di una esasperata coerenza col proprio assunto stilistico, e quindi profondamente poetico” (mai una scena col sole, sempre nuvole alte e compatte in inverno, il paese immobile nel suo “purissimo bianco e nero”, i personaggi grigi, anonimi, stremati e malati).
E aggiunge che Pandolfi ha eseguito “con assoluta severità” un obbligo religioso alla rinuncia, alla piccolezza, che si riassume nel sentimento religioso di padre Turoldo: “Se nostalgia per il mio paese e per la mia infanzia ci deve essere, non deve però abbellirli: deve anzi ridurli all’estremo”.
In altra occasione assegna Danilo Dolci e Davide Turoldo a una sezione particolare, caratterizzata da un “misticismo” che è “disperazione, povertà di forza razionale, nevrosi”. In che senso “nevrosi”? Forse nel senso di una austerità che diventa ossessione, di un grigiore quasi autoimposto, di una coerenza ostinata che però, alla fine, si identifica con la poesia e che sfiora la dimensione del sacro.
Mi ha sempre colpito il cattolicesimo di padre Turoldo: aspro, pochissimo consolatorio, macerato. Possiede una radicalità più vicina a certi scrittori cattolici francesi, come Peguy e Bernanos, e analoga a quella di Testori.
Tuttavia solo attraversando intrepidamente l’inverno della speranza, l’assenza di Dio, solo sentendo che “senza scampo sono le nostre vite”, si perviene a una fede autentica, tagliente e infrangibile come il diamante.
Una fede che coincide non con una dottrina ma con una esperienza, anche soltanto l’esperienza elementare del risveglio quotidiano di ognuno di noi, al mattino: “Ancora un’alba nel mondo / altra luce, un giorno / mai vissuto da nessuno” (Turoldo).
Ai funerali friulani di Pasolini padre Turoldo si mise a imprecare contro Roma, “maledetta capitale” che per lui compendiava l’Italia di quel periodo, con la sua “gente ingrumata e torva, con la gioventù che pensa a strappare e a uccidere”, dove “non siamo più capaci neppure di un minimo gesto di pietà” e dove diffida di un uomo di religione che non sia “uomo di Vangelo”.
A tutto questo contrappone il Friuli antico, dove il patimento genera canto: “noi siamo un popolo che canta, anche quando ha da piangere”, Esagerava, con le sue invettive e il tono profetico? Probabilmente sì, ma abbiamo tutti disperatamente bisogno di queste esagerazioni.