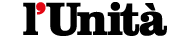Dovremmo affrettarci a dare un nome al naufragio di quattro giorni fa al largo delle coste calabresi, perché gli affondamenti senza titolo vengono presto dimenticati. Cutro o il 13 ottobre, con i cadaveri sulla spiaggia o allineati in banchina, rimangono, con la loro triste etichetta, a interrogare le nostre coscienze. Senza nome sono quasi sempre i naufragi più lontani, che si confondono tra loro e le cui vittime, anch’esse anonime, durano soltanto il tempo buono delle statistiche. A proposito: sono già 800 i morti dall’inizio dell’anno e, secondo qualcuno, questo sarebbe un dato favorevole. Quest’ultimo potremmo registrarlo come il Naufragio dei cinque giorni: tanti ce ne sono voluti perché la barca a vela – partita l’11 giugno dal porticciolo turco di Bodrum e affondata, forse dopo un’esplosione, nella notte fra domenica e lunedì – venisse finalmente raggiunta dal mercantile che ha salvato 12 superstiti (una donna è morta nel tragitto di sbarco), mentre i dispersi sarebbero 64, tra i quali 26 bambini e intere famiglie fuggite dall’Afghanistan. Poi iraniani, curdi, iracheni.
Certamente le quasi cento persone costipate nella barca durante otto giorni di navigazione, cinque dei quali trascorsi alla deriva con lo scafo che imbarca acqua, senza tregua avranno chiesto aiuto ai centri istituzionali del soccorso (le guardie costiere) e alle unità di passaggio su quel mare “forza olio”. Sarebbe stata proprio una di loro, una imbarcazione da diporto, a rimbalzare l’allarme all’IRMCC italiano, a quel punto chiamato a rispondere ad una “emergenza conclamata” (l’intervento sarebbe stato, altrimenti, derubricato a semplice operazione di polizia anti-immigrazione) in acque SAR italiane. Le ricerche, svolte in mare e in volo da assetti della Guardia Costiera e di Frontex, non hanno però dato il risultato sperato, nonostante le buone condizioni meteo-marine e l’area di ricerca relativamente ristretta. Affermano, inoltre, i sopravvissuti che molte barche sarebbero passate accanto a loro senza prestare aiuto e proprio questo tradimento, ormai ricorrente, delle regole fondamentali della marineria merita più di una riflessione. Bisognerebbe chiedersi, cioè, quanto veleno abbia riversato in mare una politica migratoria europea che, incapace di dare risposta ai fantasmi da se stessa evocati, si è ridotta a limitare e ad ostacolare i soccorsi.
Il nostro governo, prima e più degli altri, si è mosso su due assi portanti. Il primo, coerente con le politiche precedenti, consiste nell’aver ristretto gli interventi per raggio di estensione (raramente si interviene nell’area Sar libica o maltese, anche quando quei paesi non intervengono) e per criteri di intervento (se una barca galleggia e naviga, benché strapiena e in pericolo, la sua presenza riguarda la polizia e non il soccorso). Per conseguire l’obiettivo, l’esecutivo ha di fatto mutilato la nostra Guardia costiera, differenziando i soccorsi “ordinari” da quelli rivolti ai migranti (l’emergenza dei “grandi numeri”), e mortificando lo straordinario riflesso condizionato di chi esce in mare ancor prima di averci pensato, per salvare la vita di chiunque si trovi in pericolo. Sfugge spesso che i soccorsi in mare non sono soltanto il frutto di quella virtuosa capacità di reazione, ma anche il risultato di una visione strategica che solo la Guardia costiera, per posizione istituzionale, è in grado di elaborare: quella che nel 2011 la indusse a dislocare un buon numero di motovedette classe 300 (cosiddette “ogni tempo”) ancor prima che deflagrassero i numerosi sbarchi nell’anno della primavera araba.
Il secondo perno strategico governativo poggia sugli accordi con Libia e Tunisia tesi ad ostacolare le partenze usando finanziamenti e motovedette forniti dall’Italia, da tempo disinteressata alle sorti dei migranti e ai campi di prigionia, parte decisiva dell’organizzazione criminale libica. Su pressione dell’Europa, anche la Tunisia ha in questi giorni ottenuto una propria area Sar, nonostante versi in una situazione non dissimile da quella libica: a terra la persecuzione dei migranti; in mare i miliziani chiamati a catturare in tutti i modi chi prende il largo; assenza di porti sicuri: elementi che hanno indotto il Consiglio di Stato a sospendere, in via cautelare, la cessione di motovedette italiane alla Tunisia. La terza tappa sarà, dopo aver ostacolato il soccorso civile, la costosa e controversa creazione di un campo italiano in Albania. L’ispirazione governativa, esplicitata poco più di un anno fa a Cutro, si basa sull’analisi del fenomeno migratorio non quale intrattenibile flusso (peraltro, numericamente modesto) di spostamenti umani, ma come l’esito di un disegno che incrocerebbe genitori irresponsabili, rampolli in cerca di occidente e scafisti criminali.
A partire da una valutazione così ideologicamente costipata, l’obiettivo del governo si risolve nello scoraggiare le partenze: caro migrante, sarai catturato e riportato indietro e, comunque, sappi che rischieresti di morire: sto ostacolando le navi di soccorso e nessuna motovedetta italiana metterà la prua fuori dalle proprie acque Sar; in prospettiva potresti, poi, finire rinchiuso in un campo profughi albanese. Diamo, dunque, un nome anche a questo naufragio, ci serve. Il Naufragio dei Cinque giorni, oppure – ancora meglio – lasciamogli il nome di Nalina, la bambina irachena di dieci anni, scampata alla morte, che continua ancora a chiedere dove siano i suoi genitori. Sono diventati un numero, anch’essi fra gli 800 annegati di questo 2024.
*Ammiraglio in congedo