Il libro di Luigi Trucillo
Per non dimenticare i manicomi: “Antigone nella città dei pazzi” e l’imprescindibilità della poesia
Una Spoon River di internati, taluni celebri come Walser e Hoelderlin, che si riaffacciano alla storia dall’ex ricovero Bianchi di Napoli: sepolti vivi che ci interrogano sul reale senso della democrazia
Cultura - di Filippo La Porta
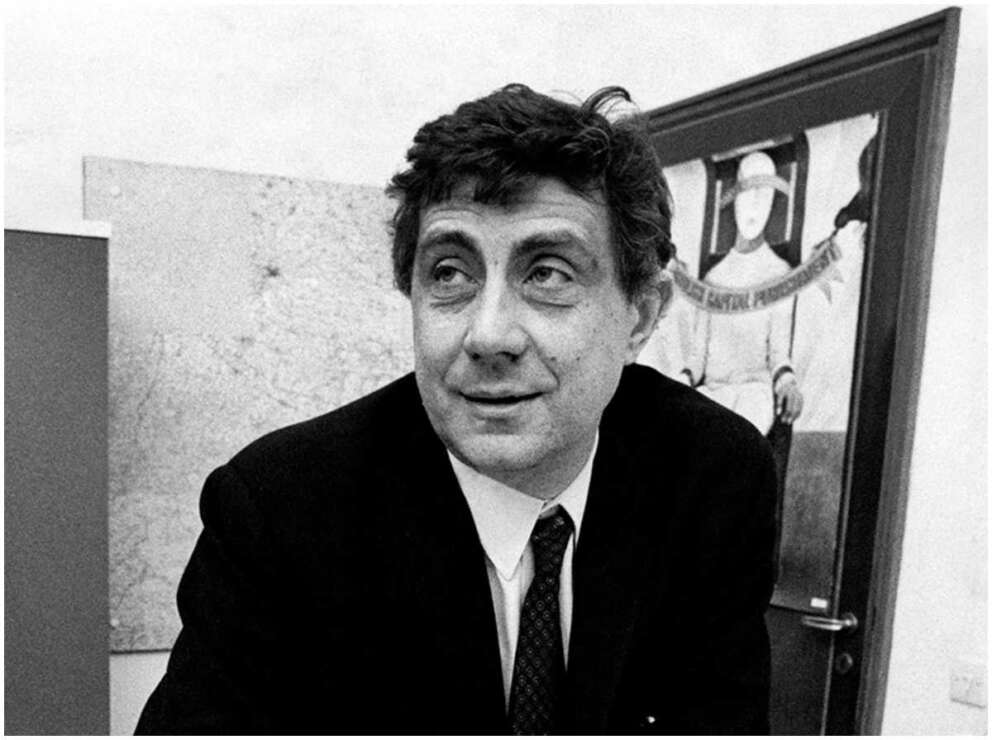
È un paradosso, ma oggi solo in poesia – un genere quasi privo di pubblico (e di critica), a dispetto delle legioni di quanti la scrivono – si può parlare di certi temi, senza diventare retorici: Dio, il Bene e il Male, la Vita e la Morte, e appunto la Follia (la malattia mentale, alla quale nessuno è davvero estraneo). Antigone e la città dei pazzi di Luigi Trucillo (Cronopio, postfazione di Antonello D’Elia), ambientato nell’ex manicomio Bianchi di Napoli, è la riscrittura in versi dell’Antigone di Sofocle.
Per fare un po’ di storia letteraria recente si potrebbe accostare a Kouros, tragedia in versi ispirata alla classicità di Ludovica Ripa di Meana, e – più indirettamente – a una singolare ripresa del romanzo in versi, come mostrano i libri di Targhetti, Frungillo, Lamberti-Bocconi, e prima ancora di Voltolini e Massini (i modelli possibili sono da un lato Attilio Bertolucci negli anni 80 e dall’altro Pagliarani negli anni 60). Perché se ne può parlare solo in poesia? Perché il linguaggio della poesia ha una libertà quasi assoluta – da nessi logico-sintattici, da ogni sequenza lineare, perfino dal significato stesso – e perché essendo la poesia una intensificazione della lingua ciò chiede al lettore una intensificazione dell’attenzione. Leggere una poesia somiglia a una preghiera laica, uno spazio irrelato, fatto di solitudine, silenzio, ascolto, uno spazio diverso da tutto il resto. Qualcuno, non particolarmente avvezzo alla poesia, mi chiede spesso perché il poeta “va a capo”. Lo fa per seguire un ritmo della frase, per assecondare una musica di quanto dice, dove quel ritmo genera ed evoca molti altri sensi oltre a quello letterale.
Si comincia con il “coro dei 4 senza 4”, cioè dei quattro elementi (acqua, aria , terra e fuoco) oggi umiliati, “dilaniati” dalla tecnica e ridotti a gas inquinanti, poi il coro si rivolge a Antigone: “Bentornata Antigone, ancora risvegliata / dal tonfo della giustizia / che come una meteora sfiora la terra”. Lei si presenta come una “lucciola” e viene invocata dal coro per “salvare il barbaglio dell’orizzonte”, per riscattare tutte le grida “degli alienati ammassati nei reparti /stretti alle brande della contenzione/”. Antigone, come sappiamo rappresenta nell’antichità una figura che si contrappone alla forza, e si potrebbe collocare accanto ad alcune scene dell’Iliade (come l’incontro tra Achille e Priamo). Il coro invita Antigone a guardarlo, “come si fissa lo sbiadire degli offesi”. Poi il poema diventa una specie di Spoon river di tutti gli internati del manicomio, ma tra le varie “lapidi” in versi troviamo anche i nomi dello stesso Basaglia, e poi di poeti che entravano e uscivano dai manicomi come Walser e Hoelderlin (manca solo Tasso a Sant’Anna) o poeti suicidi come Sylvia Plath e Majakovskij.
Queste alcune cartelle dei “pazienti” anonimi della ex casa dei matti. “Franco”: “la mia eredità è questa scatola di scarpe / che adesso è di tutti”. “Mario”: Sotto i parati o nelle federe / i brusii sono ovunque,/ con il tuo timbro, timbo, timbro”. “Modestina”: Sono in una colla compatta, / l’elettochoc delle ninfomani / candido come la merda”. “Carmela”: “Devo lavarmi le mani / ancora e ancora, / come una donna fantasma / scomparsa sotto la sporcizia della pelle”. “Maria”: “Dammi un cenno /fammi capire /in questa massa di corpi / che sa di lisciva e petrolio / che cosa stringo tra le braccia di notte”. “Luigi”: Saluto l’uniforme dell’infermiere, / Amo la mia scatola di zucchero. / Vegli sulla formica nel muretto”.
Antigone chiede pietà per tutti, per quelli che “hanno perso il diritto / di essere intravisti”, e anche “per le vittime che diventano feroci”. Qui andrebbe fatto un discorso sul marxismo, che per molte generazioni ha incarnato, legittimamente, una prospettiva di emancipazione e il sogno di una cosa. Il punto è però che degli “storti e imperfetti”, degli scarti umani e dei fatti a pezzi della vita (come li chiamava Aldo Capitini), dei sottoproletari e delle persone improduttive, il marxismo ha sempre diffidato. Non arrivano ad essere un vero soggetto sociale, capace di attivare la dialettica della Storia. Questa è probabilmente la sua vera colpa originaria, ciò che limita la sua capacità inclusiva, e su questo andrebbe molto più che solo “rifondato”.
Antigone si aggira per le stanze del Bianchi, ascoltando le voci, dialogando con gli spettri, prendendosi cura di ciò che passa, sapendo che anche lei passerà: “il tempo della morte dei miei cari / mi martella, / e sono diventata dura come il ferro / e invisibile come un addio”. Il coro le risponde, saggiamente, che chi pensa di essere il solo ad avere intelligenza è vuoto nel cuore, dal momento che “Creonte è dentro ognuno di noi / quando ci irrigidiamo / a torto o a ragione”. La consapevolezza che Creonte è dentro ciascuno di noi, potremmo dire con lieve forzatura che il fascismo è dentro ognuno di noi (forzatura perché l’antagonista di Antigone è qui il Guardiano, mentre Creonte è figura problematica, tragica), non può essere espunta da nessun antifascismo. La tragedia rappresentata da Trucillo, e che ci auguriamo venga messa prossimamente in scena, è uno straziante e ispirato poema civile, un dramma politico dalla tinta brechtiana, un manifesto poetico della democrazia. Quando Antigone dice “so che nulla è normale / quando è visto da vicino” ci evoca il Brecht di “Di nulla sia detto è naturale”, dall’ Eccezione e la regola.
Vorrei infine dedicare questo poema, che anzitutto celebra la vita, la “stella pulsante della vita” a tutti gli amici e conoscenti (perlopiù in età matura, ma non solo) convinti che sia tutto finito, esteti dell’apocalisse, già ombre dell’Ade, antinatalisti e cultori di quel cabarettista menagramo di Cioran. Antigone, che è “solo un punto di brace” attraversando il “flusso indifferente della morte” si prende carico di tutte le storie degli invisibili e dei sepolti vivi del passato, come l’angelo di Klee rievocato da Benjamin, per attualizzarle e redimerle, per risvegliare il nucleo abbagliante della promessa di libertà che pure contengono. Invoca pietà per tutti, e anche “per le parole troppo fisse”. Sapendo che l’umano è nella relazione e nella pluralità, nella “social catena” di Leopardi e nella fratellanza (un concetto usurato: forse, come accennavo, si può parlare di fratellanza solo in poesia), in una “ondata di spuma collettiva” e nell’invito di Hannah Arendt – “lucciola” del ‘900 – a far nascere sempre qualcosa: “Chi sei, fuori dagli altri?”


